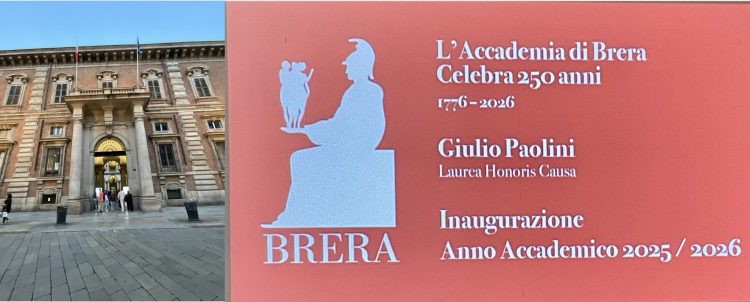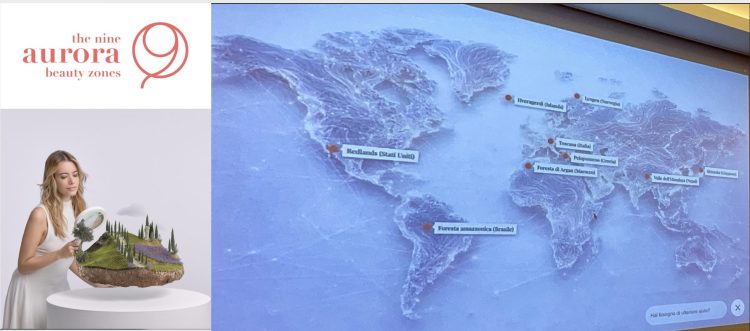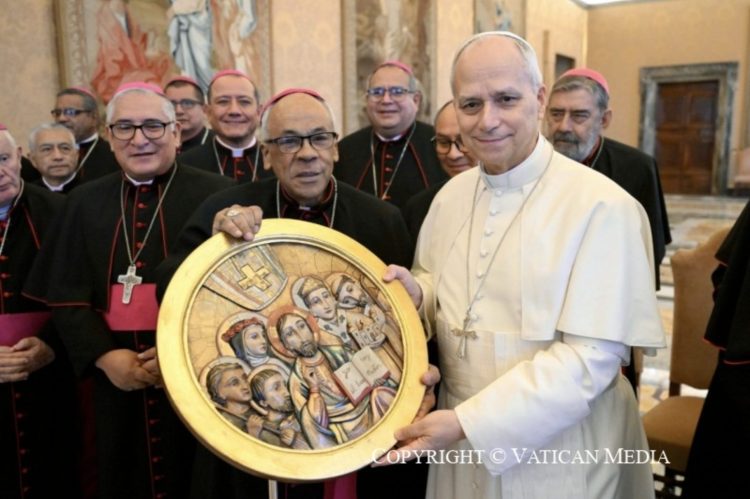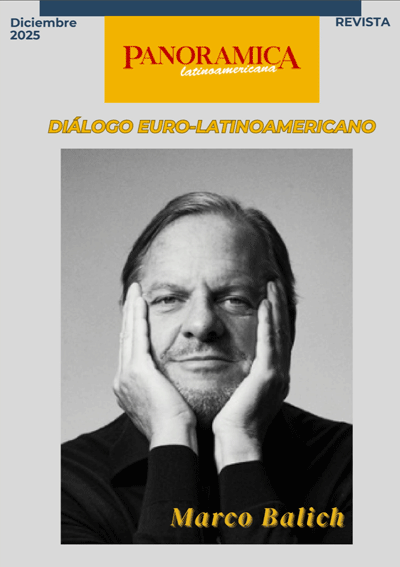Un’alleanza che unisce radici millenarie e ambizioni moderne, dal buddhismo alla Nuova Via della Seta, per ridefinire l’equilibrio globale.
Xi ha mostrato al mondo che con l’India è più forte. Pur essendo stati a lungo distanti, problemi di confini, dazi commerciali, è riuscito a recuperare ciò che secoli fa li aveva uniti: il buddhismo e i suoi principi, considerati un’alleanza tra mente e spirito. Nonostante le differenze politiche e i sistemi di vita attuali, Cina e India condividono valori profondamente radicati: il rispetto per la famiglia e la tradizione, la convinzione che l’educazione sia via di autoformazione e la ricerca filosofica dell’equilibrio e dell’armonia. Proprio questi furono i punti di incontro tra il buddhismo, l’etica confuciana e i principi taoisti: compassione, distacco, condotta morale e armonia sociale.
Le mosse di Trump, l’aumento al 50% dei dazi sull’India, le trattative ancora inconcluse con la Cina, hanno favorito questo riavvicinamento. Dal 2018 l’India non visitava la Cina: Xi ha ottenuto la ripresa di una relazione che oggi costituisce il nucleo duro della scena mondiale alla Cumbre dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Segni concreti accompagnano questo rinnovato dialogo: l’India ha ripreso a concedere visti turistici ai cittadini cinesi dal 24 luglio, dopo cinque anni, e la Cina promuove la ripresa dei voli diretti.
Si fa leva sulle antiche civiltà, nulla a che vedere con l’esperienza nordamericana o occidentale. Grecia e Cina, promotori della creazione del Foro delle Civiltà Antiche (2017), insieme a India, Egitto, Iran, Italia, Perù, Messico e Bolivia, rivendicano la continuità storica come base di legittimità. A questo si unisce la filosofia di Shanghai, riassunta nei “Principi di Shanghai”:
-
multipolarità e rifiuto dell’egemonia;
-
sicurezza condivisa (“indivisibile”);
-
fiducia reciproca e rispetto culturale (lo “spirito di Shanghai”);
-
civilizzazionalismo: il diritto delle grandi civiltà asiatiche a scegliere la propria via di sviluppo;
-
cooperazione pragmatica in economia, energia, trasporti, digitalizzazione e sicurezza.
Allontanandosi dalla pura filosofia, Xi ha saputo costruire un solido vertice con l’India, proteggere la Russia e riunire attorno a sé una fascia di Paesi satelliti. Con una eccezione: il Pakistan, alleato storico della Cina e rivale permanente dell’India, che svolge un ruolo di equilibrio delicato. L’Asia Centrale rappresenta non solo risorse energetiche, ma anche corridoi vitali per la Belt and Road Initiative. Egitto e Turchia fungono da ponti verso l’Africa e il Mediterraneo, conferendo alla SCO una dimensione extra-regionale. A tenere vivo il discorso civilizzatorio resta il soft power culturale, soprattutto nel campo educativo, che legittima in prospettiva il potere economico-politico.
In realtà, al centro vi sono denaro, credito, energia e commercio:
-
finanziamenti e prestiti: la Cina promuove da anni la creazione di una Banca di Sviluppo della SCO per espandere il proprio credito e la propria tecnologia in Asia Centrale ed Eurasia (oltre al già esistente Banco BRICS);
-
connettività e investimenti: la SCO si regge sulla possibilità di sviluppare corridoi commerciali ed energetici nell’ambito della Belt and Road;
-
mercati e catene del valore: di fronte a sanzioni e dazi occidentali, SCO assicura a Cina e Russia mercati e rotte alternative;
-
attrazione del Sud Globale: il linguaggio civilizzazionale dà legittimità a ciò che, in fondo, è un progetto economico.
La visione cinese guarda all’Occidente con calma. Dopo tutto, la sua civiltà non è stata spezzata o interrotta come nel caso del Perù o di altre regioni invase. L’Occidente, insegnando tecnologia e organizzazione industriale alla “orda di cinesi” che lavoravano per poco, ha creduto di sfruttare; oggi la Cina, capitalizzata e con brevetti propri, vende al mondo intero. Se il BRICS procede lentamente, si crea la SCO: altri soci di rilievo, altro dialogo, stessa visione civilizzatoria. La capacità di aggregare che oggi dimostra la Cina, pur mossa dall’interesse, è diversa da quella dell’Unione Europea, nata dopo due guerre mondiali: Pechino costruisce attorno a sé senza un conflitto fondativo, ma con una visione civilizzatoria ed economica che l’Occidente non ha saputo riprodurre.