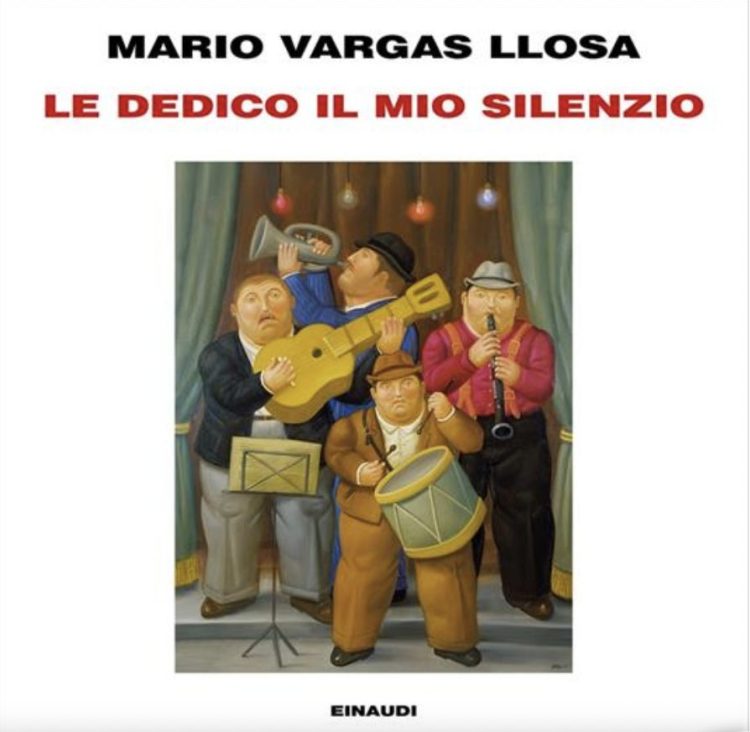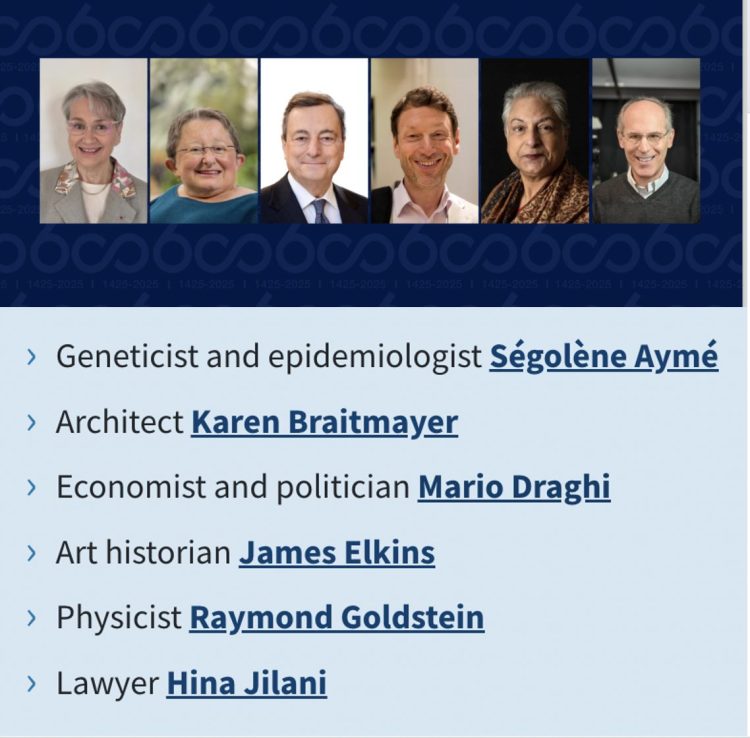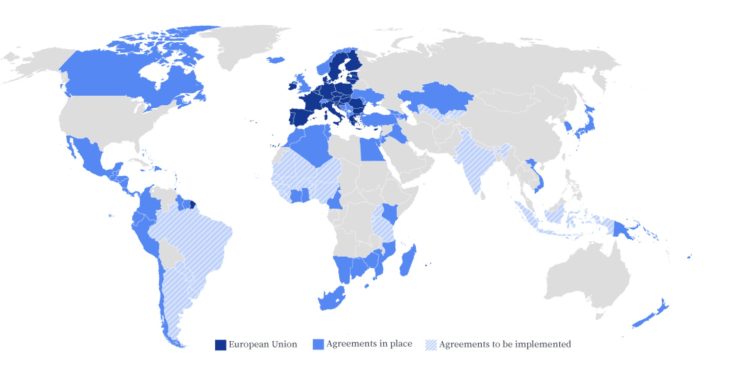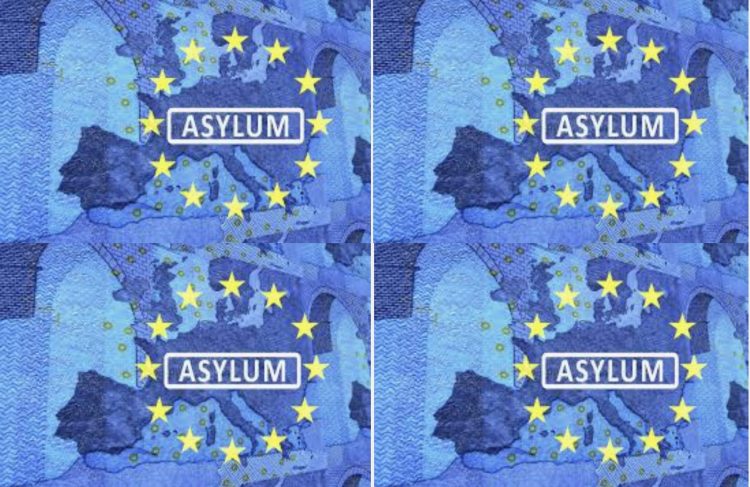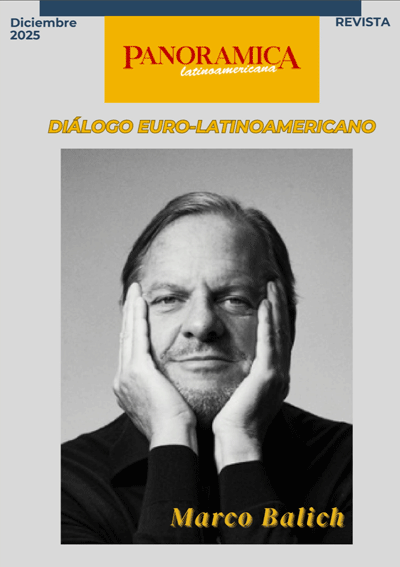L’ultimo romanzo di Mario Vargas Llosa, «Ti dedico il mio silenzio», affronta la storia della musica criolla peruviana. In esso, la musica diventa la protagonista di un racconto ambientato in un’America in cui lo spagnolo giunge a unificare lingua e cultura. Il valzer viennese e quello ispano si fondono con melodie e danze locali. I compositori dell’epoca riflettono nei testi il sentire della società, le sue esperienze e le sue emozioni. Pinglo Alva e Chabuca Granda idealizzano e unificano il Paese attraverso le loro canzoni. Il protagonista, Antonio (Toño) Azpilcueta, crede nella teoria secondo cui la musica criolla possa unire la nazione.
Tuttavia, questo romanzo si regge su due pilastri: due figure che, pur non essendo sempre in scena, plasmano il destino degli altri, ed entrambe sono italiane. Don Azpilcueta, immigrato concreto, attribuisce valore ai risultati economici; è raramente presente in casa per via del lavoro nelle ferrovie della sierra. Sposato a Chumbivilcas con una donna andina — sottomessa e affettuosa —, il suo affetto placava gli scatti d’ira del marito. Lei muore presto e lascia il protagonista, il figlio Toño, solo con il padre. Toño ricorda che l’amore per la musica popolare nasce nelle sere in cui, in grembo alla madre, ascoltava le sue canzoni. Il rapporto con il padre non sarà mai buono: non c’era dialogo. Quel vuoto diventerà fonte di stress che affiorerà nel tempo sotto forma di allucinazioni tattili — animali che gli camminano addosso — e di un prurito insopportabile. La tensione tra la durezza paterna e la sensibilità materna segna la sua formazione.
L’altro protagonista è don Oreste Molfino, prete italiano che vive nel porto di Etén, una zona abbandonata dallo Stato peruviano, dove la povertà è il denominatore comune. In una discarica trova un neonato lasciato in pasto agli animali; il pianto lo salva. Don Oreste, generoso e dedito alla comunità, lo adotta, lo cresce, lo educa. Quel bambino diventerà Lalo Molfino. Nella stessa discarica Lalo trova una chitarra, che diventa il centro della sua vita: autodidatta, suonerà in modo folgorante. Lalo non vuole proseguire con le superiori: vuole solo suonare; don Oreste lo lascia fare e lo accompagna. A un certo punto, sentendo avvicinarsi la morte, il sacerdote torna in Italia.
L’incontro di Toño con Lalo avviene al di là del Rímac, in quella Lima che comincia oltre il fiume. Lalo — chitarra in spalla, scarpe di vernice senza calze — gli riaccende la speranza e Toño decide di intervistarlo. Nella ricerca scopre che Lalo è morto e, peggio ancora, che è stato sepolto in una fossa comune per mancanza di familiari che lo reclamassero. Toño trova allora la motivazione della sua vita: rendere giustizia a quella morte ingiusta. Decide di scrivere un libro su Lalo e intraprende un viaggio nel Nord — Chiclayo, il porto di Etén. Racconta la sua vita e alterna riflessioni sull’unità sociale attraverso il valzer criollo. Prende ad esempio una coppia che sfida i pregiudizi: Lala, donna nera di una zona emarginata, e Alfredo, giovane bianco di buona famiglia limeña; contro ogni convenzione, si sposano e il matrimonio dura nel tempo. Quell’unione ispira l’idea di un Perù possibile, dove razze e culture diverse costruiscono insieme.
Ma l’ossessione di Toño per il libro perfetto su Lalo — la musica criolla, l’unità del Perù attraverso l’arte — lo esonera dalle responsabilità familiari: ignora la moglie, Matilde, la casa, le figlie. Idealizza una famosa cantante criolla, la colma di attenzioni e finisce per misurare la propria affermazione in base alla sua approvazione e ai suoi elogi. Matilde regge la casa in silenzio.

La musica è la cornice, sì. Ma il fulcro del romanzo è altrove: nella figura del prete italiano che adotta il giovane chitarrista. Quell’uomo, generoso e libero, offre cura senza pretese. Grazie a lui, il chitarrista diventa simbolo, mito, possibilità. Senza quella libertà, il suo destino sarebbe stato incerto.
Il romanzo mette a confronto due modelli di mascolinità: il padre di Toño, don Azpilcueta, italiano autoritario, centrato su denaro e controllo; e il prete, anch’egli italiano, ma affettivo e orizzontale, capace di donare senza aspettarsi nulla. Vargas Llosa suggerisce che l’arte, da sola, non salva: ciò che salva è l’amore che permette di essere. Nella sua ossessione, Toño arriva sull’orlo della follia. «Ti dedico il mio silenzio» è la frase che Lalo pronuncia quando viene congedato dal suo ultimo lavoro come chitarrista inadatto in una compagnia di musicisti: la sua continua incapacità di convivenza, unita a un ego smisurato, gli impedisce di integrarsi. È il costo umano di certe utopie maschili. Il romanzo guarda anche alle donne che sostengono, attendono, scompaiono. E agli uomini che, nel desiderio di riscatto, dimenticano che il miracolo accade quando capiscono di non essere gli unici ad avere obiettivi nella vita.