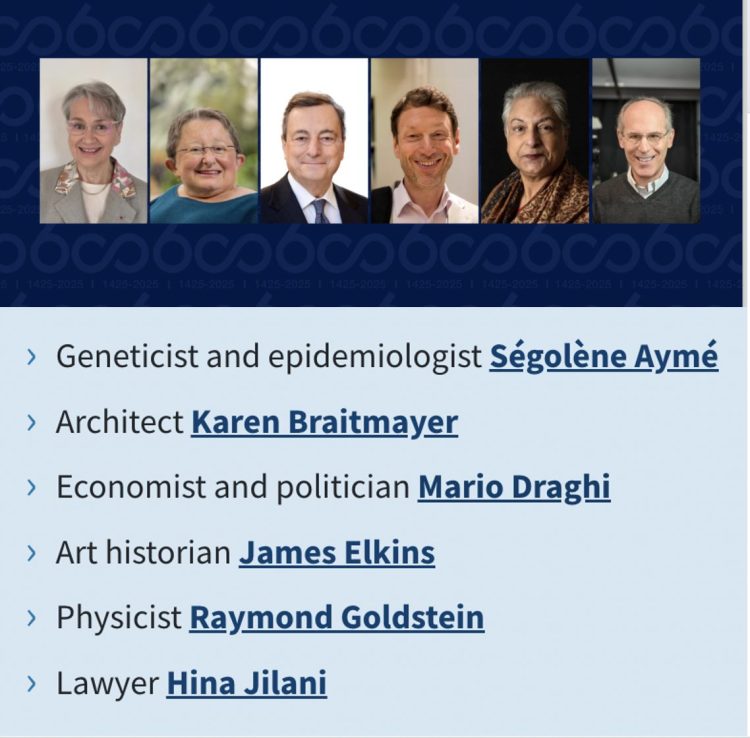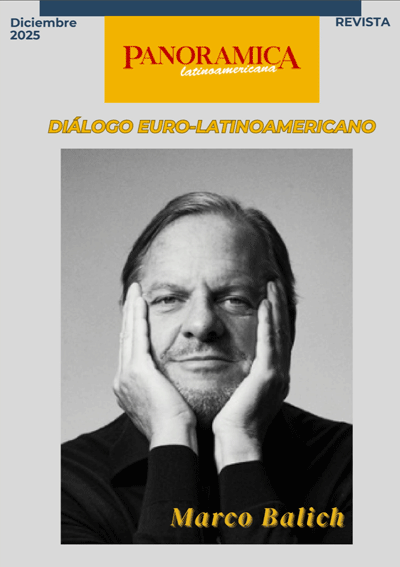Posso parlare degli anni ’80, quando le donne italiane indossavano un mix di abiti da casalinga e da sera. Non esisteva ancora un dress code per professionisti sicuri di sé e pronti a fare carriera.
In un’Europa dove «l’abito fa il monaco» (l’abbigliamento definisce il ruolo), tutti si vestivano in base al proprio lavoro: l’operaio in tuta, il fornaio in grembiule bianco, la segretaria in uniforme e golfino. Fu Giorgio Armani a rompere gli schemi: decostruì il guardaroba maschile e creò un abbigliamento dirigenziale per le donne, con giacche dalle spalle pronunciate, pantaloni ampi e silhouette che trasmettevano autorevolezza senza sacrificare la femminilità.
Con Armani, molte donne scoprirono un nuovo modo di essere sul posto di lavoro.
Il tailleur cessò di essere un simbolo esclusivamente maschile e divenne uno strumento di presenza, autorità e rispetto.
Armani aveva una visione molto chiara di come uomini e donne dovessero vestirsi. Studiò medicina e comprese il corpo umano. Dopo aver completato il servizio militare, abbandonò la medicina e andò a lavorare alla Rinascente, il grande magazzino milanese che assunse quel nome nel 1917 dopo che un incendio distrusse la precedente attività. I fratelli Bocconi trasferirono la loro attività sartoriale nel centro di Milano, in Piazza del Duomo. Stiamo parlando degli stessi fratelli Bocconi che diedero vita all’omonima Università. Tre tradizioni che definiscono Milano: artigianalità, studio accademico e creatività. Armani iniziò come vetrinista, disegnando splendide vetrine che attirarono rapidamente l’attenzione.
Il suo talento fu riconosciuto da Nino Cerruti, Nino Cerruti volle incontrarlo e gli propose di lavorare con lui nell’omonimo lanificio. Iniziò con la linea di abbigliamento maschile Hitman e in seguito come stilista. Acquisì esperienza. Fu lì che Armani iniziò a disegnare, acquisendo esperienza. Poco dopo, incontrò l’architetto e manager Sergio Galeotti, suo compagno di vita e di lavoro, con il quale fondò il marchio Giorgio Armani nel 1975. Armani non si considerò mai un sarto o una sarta: si definiva uno stilista, un creatore di stile.
Per lui, i tessuti erano fondamentali: consistenza, drappeggio, texture. Le sue creazioni erano pensate per la quotidianità, non per la fantasia dello spettacolo. Ricordava sempre: «Un abito è la nostra seconda pelle». La sua autenticità inaugurò un’epoca: milioni di donne adattarono persino il loro corpo ai suoi tailleur.
La morte di Galeotti fu un colpo devastante per Armani. Ciononostante, continuò a lavorare per l’azienda, supportato dalla nipote Silvia Armani e da Leo Dell’Orco, il suo attuale socio, con cui apparve mano nella mano nella sua ultima sfilata.
Armani non solo consolidò un impero della moda, ma fece anche di Milano l’epicentro mondiale dell’eleganza, al fianco di altri grandi nomi come Gianfranco Ferré, Valentino, Max Mara e molti altri. Era il milanese per eccellenza: austero, instancabile, laborioso. «Si sedeva e restava seduto a lavorare», dicevano di lui.
Fino ai suoi ultimi giorni, dimostrò un attaccamento alla vita italiana. La scorsa settimana ha acquistato La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi (Lucca), un leggendario ristorante e night club fondato nel 1929, dove incontrò Galeotti. Più che un investimento, è stato un gesto d’affetto, un omaggio ai luoghi di ritrovo italiani, alla buona cucina e al divertimento.
La sua azienda ha sempre sostenuto la moda sostenibile e promosso campagne umanitarie. I proventi di Acqua di Giò hanno sostenuto l’UNICEF e la lotta contro l’AIDS.
A 91 anni, Giorgio Armani ha lasciato un segno unico. Era più di uno stilista: era un architetto dell’eleganza moderna, un costruttore di simboli discreti e un imprenditore che ha messo il design al centro di tutto. La sua famosa citazione lo riassume:
«L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare».
Grazie, Giorgio. Milano e il mondo intero ti ricorderanno per sempre.