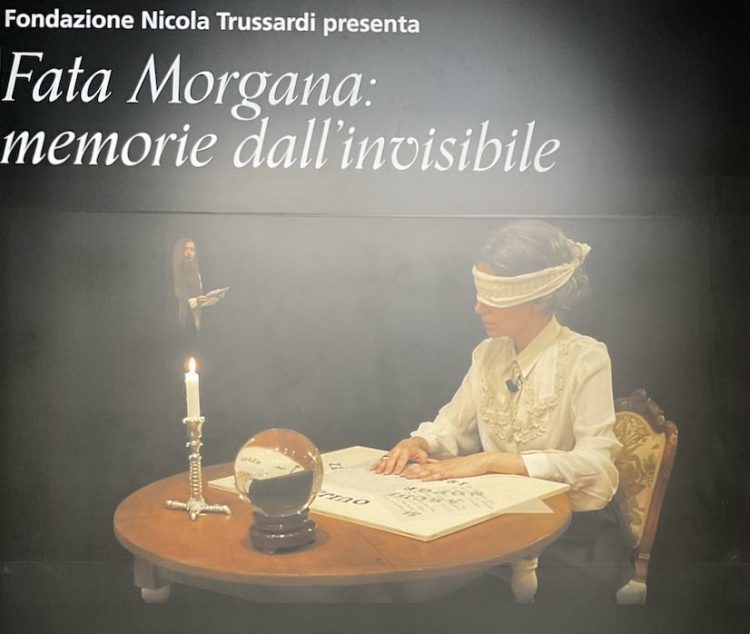Angelo Santagostino
La Tunisia sta vivendo una duplice crisi. Quella politico-istituzionale. Quella degli approvvigionamenti di grano a causa della guerra della Russia in Ucraina.
Il 25 luglio 2021 il presidente della Repubblica Kais Saied sospendeva il Parlamento, accusando di corruzione il partito di maggioranza relativa e di ispirazione islamista Ennahda e il suo leader storico Rached Ghannouchi. Il 25 luglio 2022 il popolo tunisino sarà chiamato a votare la nuova Costituzione, fatta preparare dal Presidente Saied. “Non si tratta né di un sistema parlamentare, né di un sistema presidenziale o semi-presidenziale, ma di un sistema tunisino”. Così si è espresso uno degli estensori e collaboratori di Saied. Cosa debba intendersi per sistema tunisino non lo ha precisato, ma forse lo si può desumere da uno dei poteri presidenziali: quello della scelta del premier. Non sarà infatti tenuto a incaricare il leader del partito più votato. Se, la persona o le persone da lui scelte non riusciranno a ottenere la fiducia del Parlamento, allora il Presidente potrà scioglierlo. Come dire, o vi è un governo, di fatto, del Presidente o si torna a votare. Non è, tuttavia, indicato il termine entro il quale il capo dello Stato è tenuto a convocare nuove elezioni.
Il referendum del 25 luglio si svolgerà in un clima sociale molto teso. Il governo ha presentato recentemente un piano economico, concordato con il Fmi, orientato a congelare i salari e le assunzioni nel settore pubblico, così come a razionalizzare le sovvenzioni per la benzina e le derrate alimentati, a partire dal 2023, ciò allo scopo di arrestare il deterioramento delle finanze pubbliche. Ma sarà ben difficile farle accettare, data l’opposizione del potente sindacato Ugtt, strenuo difensore dei salari del settore pubblico. Attualmente il debito pubblico è pari al 95% del Pil, meglio di alcuni paesi europei, ma il 60% è in mano a investitori esteri. A ciò si aggiunge un déficit in crescita del bilancio pubblico, dal 6% al 10% del Pil tra il 2021 e il 2022. Il deficit commerciale, nei primi cinque mesi del 2022, ha toccato i 3 miliardi di euro. La Tunisia risente dell’inflazione globale, mentre la sua economia da un lato soffre ancora le conseguenze della pandemia, anche se il turismo è in forte ripresa, e dall’altro di una mancanza di investimenti. In parte questa è dovuta alla congerie di regole burocratiche, in parte al clima di scarsa sicurezza in cui sta cadendo il Paese. A fine giugno il ministero degli Interni ha diramato un allarme circa la possibilità di attacchi terroristici e di possibili attentati alla vita del Presidente. Di recente, due tentativi sarebbero stati sventati all’ultimo momento. La Tunisia dipende per il 60% del suo fabbisogno dalle importazioni di grano dall’Ucraina. La produzione locale copre il resto. Quest’anno il raccolto è stato particolarmente buono, un 30% in più. Servirà a coprire il fabbisogno per ancora due o tre mesi, ma poi sarà crisi alimentare se le forniture non saranno ristabilite. Cosa vera non solo per la Tunisia, ma anche per altri paesi del Nord-Africa o dell’Asia, come il Pakistan. Il problema della Tunisia è il divario tra fabbisogno e consumi di pane. Il primo è superiore al secondo, le stime del gap sono incerte, ma il 15-20% è una buona approssimazione. Perché questo divario? Per via del sussidio del prezzo della baguette. Costa 200 millesimi di dinaro, ossia 5 centesimi di euro. Un prezzo irrisorio, anche in un paese tutto sommato povero come la Tunisia. Di conseguenza vi è un eccesso di acquisto, di domanda delle baguette rispetto al consumo. Un fenomeno anche visivo, dalle panetterie gli acquirenti escono con 5 baguette, ossia spendono un dinaro. Non tutto questo pane viene tuttavia consumato, e anche questo è un fenomeno visivo. Nelle strade, appesi a un palo, al tronco di un albero o ad altro, abbondano sacchetti contenenti il pane non consumato in famiglia, e non si tratta di piccole dosi, a disposizione di chi intenda prenderseli, ma soprattutto della nettezza urbana. Ciò spiega il fabbisogno superiore al consumo. Di fatto, quindi, il consumatore paga più di 5 centesimi di euro per la baguette intera, in quanto ne consuma solo un parte. Eppure se il prezzo politico venisse aumentato solo di quel 15-20%, tanto da riequilibrare fabbisogno e consumo, scoppierebbe la rivoluzione. Darebbe infatti alle frange estremiste, ossia all’Islam radicale, il pretesto per soffiare sullo scontento. Del resto le cosiddette primavere arabe sono cominciate proprio in Tunisia, a seguito di aumenti dei prezzi dei grani. Il pericolo di una ripetizione è molto concreto, legato agli approvvigionamenti dei prossimi mesi. Quella rivoluzione, pilotata dai partiti islamici come Ennahda, ma anche da gruppi radicali, portò alla defenestrazione nel 2011 dell’allora presidente Ben Ali, riparato in Arabia saudita dove poi morì. L’attuale presidente Kais Saied è il sesto dalla caduta di Ben Alì. Ciò indica quanta instabilità sia seguita alla Rivoluzione dei gelsomini.
Forse per questo la nostalgia per Ben Alì è tanta. È nostalgico il taxista, perché allora tutto costava meno e le corse erano di più; è nostalgico il cameriere, perché vi erano più turisti e quindi più lavoro e più mance; sono nostalgici i dipendenti pubblici, per via dei migliori stipendi di cui godevano; sono nostalgici gli ambienti degli affari. In definitiva l’esperienza parlamentare, quella dei rappresentanti eletti dal popolo, è vista come fallimentare.
Quel moto rivoluzionario, la quale in Europa si guardò con troppo ottimismo, come a una ricerca della democrazia, fu realtà in realtà strumentalizzato da movimenti islamici radicali, il cui scopo era piuttosto sostituire una dittatura con altra, e non certo migliore. I golpe del 25 luglio 2021 fu la reazione laica a chi intendeva fare della Tunisia uno stato islamico. Il referendum, a un anno di distanza, segnerà l’avvio di una nuova fase. Dubbio se sarà democratica, nel senso europeo. Ma quello tunisino è un mondo arabo, con logiche e soluzioni inevitabilmente diverse e stridenti con quelle delle democrazie liberali, prodotto di una cultura della quale vi sono sì manifestazioni, ma rimangono in superficie, senza possibilità di penetrare nel tessuto sociale.
Angelo Santagostino. Nato a Milano, 1947.
Professore Jean Monnet, Cattedra ad personam, in Integrazione Economica Europea presso l’Università di Ankara Yildirim Beyazit, (2013-2021) e presso l’Università di Brescia, Italia (1997-2012). Ha insegnato in diverse università europee e latinoamericane.