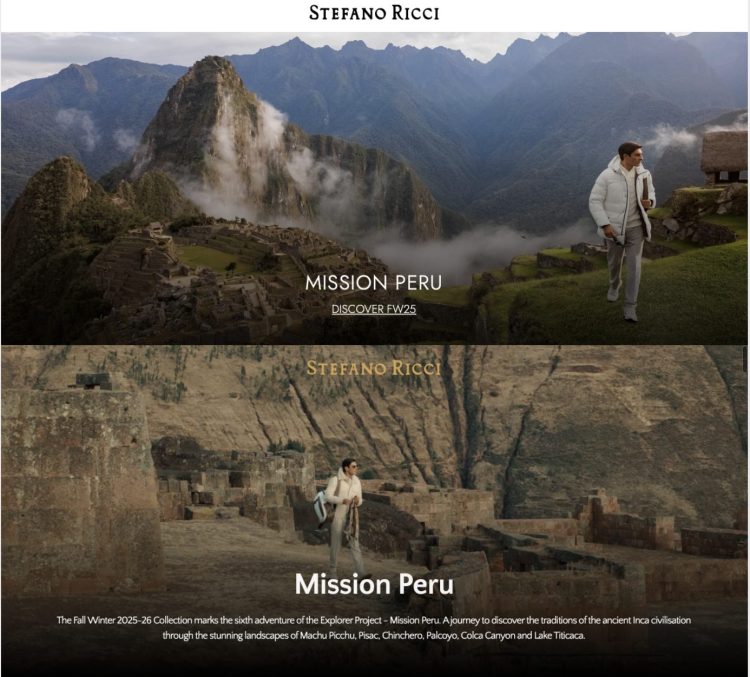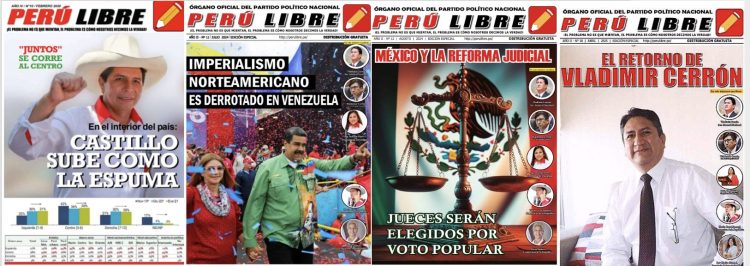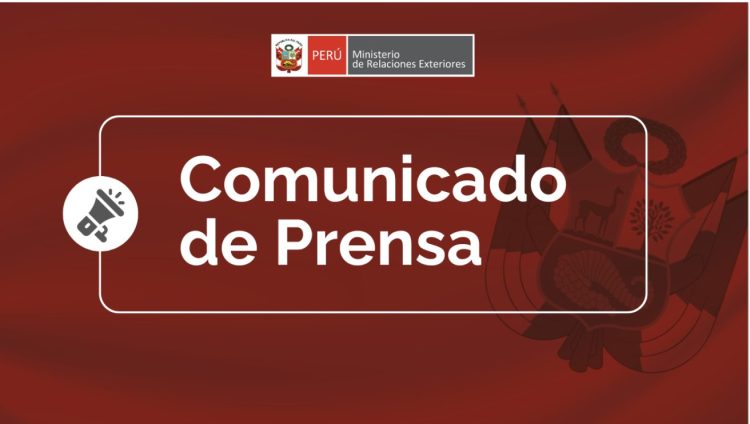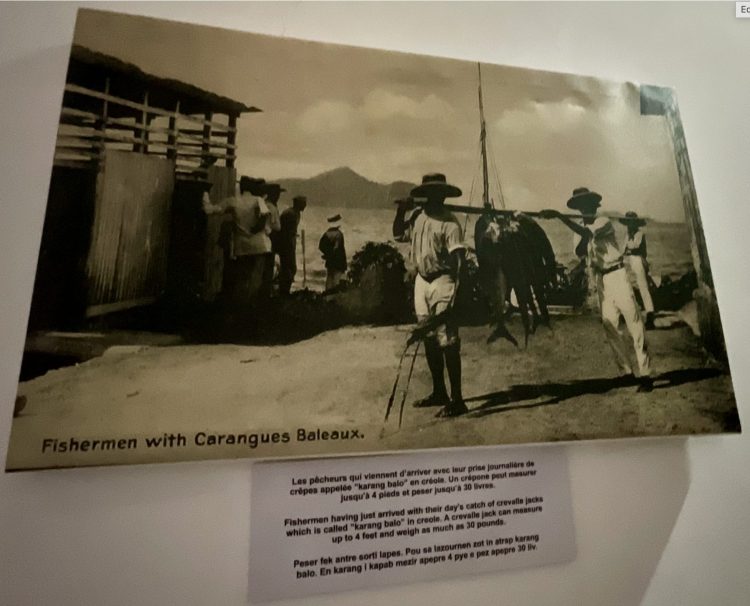Prima di tutto, vediamo dal punto di vista legislativo se ci sono misure di tutela e di impulso per la partecipazione femminile alla vita politica nel nostro paese:
- La nostra costituzione, in tema di partecipazione alla vita politica, prevede all’articolo 51, primo comma, che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Nel 2003 poi quando è intercorsa una legge costituzionale di modifica della Costituzione (L. Cost. n. 1/2003), è stato aggiunto un periodo secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
- A livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non deve essere un ostacolo per misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (art. 23 inserito nel Capo III relativo all’uguaglianza).
- Infine secondo una ulteriore modifica alla nostra costituzione viene stabilito che le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- Ci sono poi dei meccanismi premiali a vantaggio dei partiti che eleggono candidati di entrambe i sessi, mentre ci sono meccanismi punitivi nei confronti di partiti che non abbiano destinato somme di finanziamento derivanti dal 2 per mille ad iniziative a favore della presenza attiva delle donne alla vita politica
E’ importante vedere qualche dato statistico per capire a che punto siamo in Italia.
Nel 2020 l’indice sull’uguaglianza di genere (che viene elaborato dall’EIGE agenzia autonoma dell’UE – Istituto europeo per l’uguaglianza di genere) mostra che l’Italia è tra i Paesi che hanno fatto registrare i maggiori progressi tra tutti gli Stati membri dell’UE per due anni consecutivi.
Il maggior successo raggiunto – nel complesso dei paesi e in Italia in particolare – riguarda l’ambito del potere decisionale (politico, economico e sociale), dove l’Italia ha guadagnato 29 punti.
I miglioramenti italiani sono dovuti soprattutto ai due interventi legislativi che hanno modificato:
- a) la composizione delle liste elettorali (già nella passata legislatura, in conseguenza della norma sull’alternanza uomo-donna nelle liste e la possibilità di esprimere una seconda preferenza purché riferita a un candidato di sesso diverso dalla prima, era molto aumentata la percentuale di donne in Parlamento);
- b) la composizione delle società quotate in borsa.
Quindi si tratta di una maggiore presenza formale, ma non sostanziale.
La posizione dell’Italia è molto in basso nella graduatoria della presenza femminile dei paesi dell’UE in tutti i settori, ad eccezione di quello della salute.
Le disuguaglianze di genere sono più marcate:
– nei settori del potere, quindi nelle posizioni di potere decisionale ed economico;
– nel settore del tempo (59,3 punti), cioè nel tempo dedicato ai lavori domestici e all’assistenza, mentre le attività sociali sono in aumento.
– nel settore della conoscenza (61,9 punti), cioè della formazione universitaria.
Sappiamo che l’Italia ha il punteggio più basso di tutti gli Stati membri dell’UE nel settore dell’occupazione femminile.
I dati relativi alla presenza femminile negli organi costituzionali italiani hanno sempre mostrato una presenza contenuta nei numeri e molto limitata quanto alle posizioni di vertice.
Quanto alle posizioni di vertice, nessuna donna in Italia ha mai rivestito la carica di Capo dello Stato o di Presidente del Consiglio.
Abbiamo avuto 4 donne nel ruolo di Presidente della Camera dei deputati, mentre per la prima volta in questa legislatura è stata eletta una donna come Presidente del senato.
Invece i dati sulla presenza femminile in politica segna una inversione di tendenza negli ultimi anni, ma è bene chiarire che è dovuta alla legge elettorale n. 165 del 2017 che promuove la parità di genere nella rappresentanza politica.
Nella attuale legislatura la percentuale di donne elette alla Camera risulta pari al 35,7% (225 su 630), in crescita del +4% rispetto alla precedente legislatura; al Senato della Repubblica la presenza femminile è del 34,9 %).
Alla Camera in 6 commissioni parlamentari su 14 (luoghi importantissimi nei quali si portano avanti i testi legislativi) ci sono presidenti donne:
Commissione Cultura, scienza e istruzione- Commissione Ambiente- Commissione trasporti-Commissione attività produttive – Commissione lavoro -Commissione affari sociali
Al Senato la presidenza è assegnata ad una donna in 4 Commissioni:
Commissione difesa, Commissione lavoro, Commissione sanità, Commissione ambiente.
Perché la presenza femminile in politica è scarsa e soprattutto non è portatrice di cambiamenti nella società?
Prima di tutto per motivi sociologici.
La persistenza di ruoli e stereotipi di genere influenza il tipo di partecipazione politica degli adolescenti e dei giovani adulti in Italia: i ragazzi tendono infatti ad impegnarsi più spesso in attività di politica istituzionale, come iscriversi ad un partito e cercare di influenzare l’azione di governo, mentre le ragazze preferiscono optare per attività legate alla partecipazione civica, come volontariato, donazioni, petizioni e boicottaggi.
Per motivi educativi.
Le ragazze non sono abbastanza accompagnate ed incentivate ad esercitare ruoli di leadership, a sperimentare le loro capacità e ad acquisire consapevolezza critica rispetto ai vincoli e alle barriere che dovranno affrontare fin da giovani e poi da adulte.
Per motivi politici di lungo termine
Le misure di incremento della presenza femminile sulla scena politica non determinano un rinnovamento della vita sociale e della crescita femminile. Le politiche sono settoriali e non hanno una visione sistemica.
Tutte le scelte dovrebbero essere interconnesse. Dovrebbero camminare di pari passo con le politiche di incentivo allo studio delle materie scientifiche, di educazione finanziaria, di prevenzione della violenza contro le donne, con l’aumento del credito per le nuove imprese femminili, con una nuova visione delle città a misura di donna.
La presenza femminile in politica non si traduce in misure sostanziali e durature di inclusione, di cura, di miglioramento dei tempi di vita e di lavoro, di rispetto delle diversità, di crescita economica.